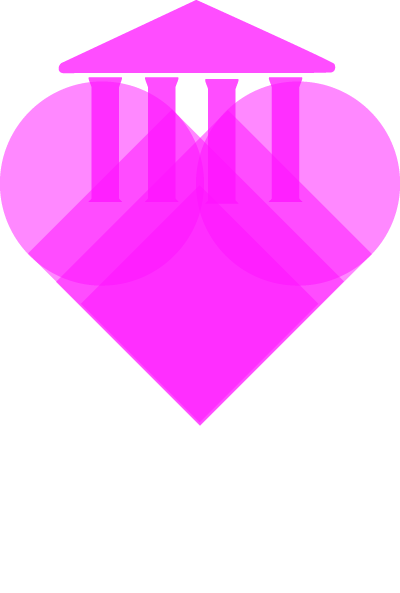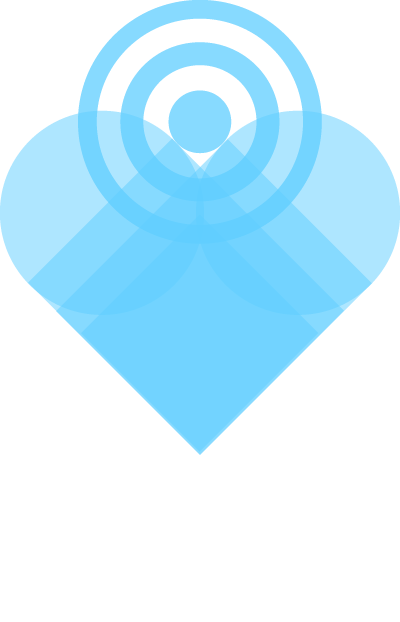L’abbazia di Monteveglio è uno dei luoghi più caratteristici della Val Samoggia. Sulla cima di una breve asperità, ma che sembra immensa nell’infinita distesa della Pianura Padana, ha una storia più che millenaria, e affonda le sue radici agli albori della Cristianità. La Val Samoggia stessa, d’altronde, è un concentrato di storia, coi suoi castelli, i suoi borghi e i suoi scavi archeologici. Raggiungere la destinazione senza macchina non è facile: l’abbazia di Monteveglio, infatti, è piuttosto isolata. Col treno si scende alla stazione di Bazzano (capoluogo del nuovo comune di Valsamoggia) e da qui si prosegue con l’autobus 656 fino a Monteveglio Ponte. All’abbazia, infine, si arriva a piedi, poco meno di un paio di chilometri lungo una salita alberata.
Il borgo medievale
L’abbazia di Monteveglio si trova all’interno di un borgo medievale adagiato sul fianco di un calanco gessoso. Un borgo particolare, allineato su un’unica lunga via longitudinale, che termina proprio davanti alla pieve e all’abbazia. Già nel corso della salita si respira l’aria di un luogo antico ed evocativo. Là, oltre le curve, s’erge improvvisa una torre merlata a nido di rondine, massiccia e potente col suo zoccolo in muratura. Al suo fianco, un arco di pietre squadrate fa da confine tra il borgo e il resto del mondo. Intorno, s’apre un brullo declivio colmo di sterpaglie, dove la vegetazione domina la scena, e qua e la affiorano concrezioni gessose col loro ruvido biancore. Attraversato quindi l’arco, si percorre una tortuosa via acciottolata, un continuo saliscendi fiancheggiato da alberi, torri e case dalla grezza muratura.

Un borgo di campagna, dunque, creato dal secolare camminare lungo la via maestra. Si percorre con calma, respirando l’immobile tranquillità del luogo, lasciando che la sagoma della pieve di Monteveglio si schiuda pian piano. Ecco, infatti, che le sue forme romaniche appaiono in fondo alla strada, mentre il rosso laterizio s’accende illuminato dal sole. Il primo a lasciarsi mostrare è il fianco, alto, tozzo e severo, con uno zoccolo in pietra e gli immancabili archetti a coronamento. Per osservare la facciata occorre ancora qualche passo, dal momento che si affaccia sul piazzale al termine della lunga strada del borgo. Quando la vedi, però, respiri subito medioevo, con la sua forma che riflette la divisione a tre navate all’interno, la piccola bifora al centro e il portale strombato. Un insieme così armonioso che risulta difficile crederlo come il frutto di un restauro in stile degli anni ‘20.
L’abbazia di Monteveglio
Le origini affondano nel mito. La pieve è citata in documenti del 953, ma la sua fondazione è ancora più antica, dal momento che si erge sui resti di un tempio romano. L’abbazia, invece, risale alla fine del XII secolo, voluta da una delle donne più famose e potenti della storia: Matilde di Canossa. Nei secoli il complesso di Monteveglio subì vari momenti di decadenza e di ripresa, inclusa la soppressione durante gli anni di Napoleone. Nel Seicento, inoltre, la pieve fu rimodernata secondo il gusto barocco, con nuovi altari e decorazioni, tutti eliminati nel corso del già citato restauro novecentesco. Per questo la pieve si presenta un po’ spoglia, col cotto a vista, senza pitture. L’architettura, al contrario, riflette quella di molte chiese romaniche, con l’altare su un piano rialzato sotto cui giace la cripta.

La cripta è la parte più interessante del complesso di Monteveglio, oltre quella più antica. Qui una foresta di colonne sostiene volte continue, con alcuni capitelli più antichi della chiesa stessa. L’altare, invece, è ricavato da una lastra romana, mentre il fonte battesimale è tra i pochi manufatti longobardi ancora oggi esistenti. L’abbazia è ancora oggi luogo di preghiera, in quanto ospita una comunità di frati francescani. Si articola intorno ad un chiostro quattrocentesco, con due pozzi in pietra, che si può visitare chiedendo il permesso ai frati. Esiste anche parte dell’originale chiostro romanico, col loggiato esposto a nord; purtroppo si è salvato soltanto un lato, dal momento che nell’Ottocento furono battuti gli altri tre. Di fronte alla pieve, infine, si aprono una serie di archi che accompagnano verso il sotterraneo fortificato, retaggio dell’epoca delle costanti guerre tra Modena e Bologna.

Il parco
Visitati borgo e pieve, non rimane altro che immergersi nell’ambiente circostante. Come accennato, il borgo è attorniato da una natura brulla e selvaggia, che scende a balzi fino alla pianura. Lunghe camminate si snodano tra calanchi e boschetti, piccole valli e rilievi improvvisi. Una consuetudine nel bolognese, dove il gesso la fa da padrone. Voltandosi, si osserva un panorama esteso, con paesi immersi nel verde e colline aguzze, che lasciano intravedere spicchi dell’infinita pianura padana. Un patrimonio naturale protetto fin dal 1995, quando lo Regione Emilia-Romagna lo elevò a parco regionale.
Un luogo ameno, tranquillo e sereno, a cui abbandonarsi con cuore leggero.